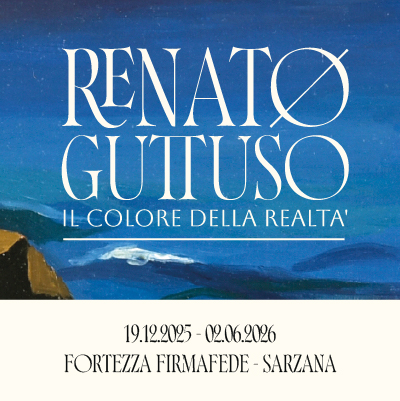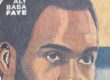Il 5 novembre 2025 la Tornabuoni Arte di Roma ha aperto le porte a Rosso Shakespeare, la nuova mostra dedicata a Emilio Isgrò, una delle figure più originali e complesse dell’arte italiana contemporanea. Poeta, scrittore, drammaturgo, ma anche pittore e artista concettuale, Isgrò (Barcellona di Sicilia, 1937) ha costruito, nell’arco di oltre sei decenni, un’opera che sfida le definizioni e dissolve i confini tra parola e immagine, tra letteratura e arti visive. La mostra romana, che nasce con l’intento di tracciare un dialogo tra gli scritti e le opere visive dell’artista, indaga il punto esatto in cui “finisce la parola e comincia l’immagine”, come scrivono i curatori.
E non poteva esserci soggetto più adatto di Shakespeare, il poeta per eccellenza, per riflettere sulla vitalità della parola e sul suo potere di rinascita anche attraverso la negazione. Nelle ultime due sale della mostra, i lavori dedicati a Romeo e Giulietta (2022) e Othello (2019) — rispettivamente composti da 38 e 36 volumi — esplodono in un vibrante “rosso cancellatura” che trasforma il gesto distruttivo in un atto poetico. La cancellatura, cifra stilistica di Isgrò fin dagli anni Sessanta, non è mai mera negazione: è, come afferma lui stesso, “affermazione di nuovi significati, trasformazione di un segno negativo in azione positiva”. Sono esposti in mostra da un lato i testi per il teatro, le raccolte di poesia, i romanzi e dall’altro opere visive che hanno soggetti letterari, o legati alla scrittura: aprono il percorso opere degli anni Settanta fra cui Vitale (1972), seguite da un lavoro sull’Odissea, Odysséus (2018), e uno sulla prima pagina del «Corriere della Sera» Ala italiana, Corriere (2013).

Dalla poesia alla cancellatura
Isgrò nasce come poeta e scrittore. Le sue prime poesie, pubblicate nel 1956 da Schwarz, furono notate da Pier Paolo Pasolini, che gli dedicò un articolo su Il Punto nel maggio del 1957. Amico di Eugenio Montale — che arrivò a togliergli il saluto quando Isgrò, nel 1966, dichiarò provocatoriamente “la parola è morta” —, collaborò con figure come Elio Vittorini e Italo Calvino, che pubblicarono una sua raccolta poetica sul Menabò di Einaudi. La sua carriera letteraria è costellata di romanzi editi da Feltrinelli, Mondadori e Sellerio, tra cui L’avventurosa vita di Emilio Isgrò, candidato al Premio Strega e recentemente riproposto da Interlinea.
Accanto alla scrittura, la sua attività giornalistica ha avuto un ruolo cruciale nella nascita della cancellatura: quando, da redattore de Il Gazzettino di Venezia, si trovò a correggere un testo di Giovanni Comisso cancellando ciò che gli sembrava superfluo, intuì che quel gesto poteva diventare linguaggio. Negli anni successivi collaborò con Oggi sotto la direzione di Enzo Biagi e, più di recente, con Il Corriere della Sera e La Lettura, segno di una costante riflessione sulla parola scritta, anche nel suo uso giornalistico.
La scena, la città, la memoria
Non solo libri e quadri: Isgrò ha portato la parola anche sulla scena. Chiamato da Ludovico Corrao a Gibellina, la città siciliana distrutta dal terremoto del 1968, realizzò L’Orestea di Gibellina, una trilogia teatrale rappresentata tra le rovine del paese dal 1983 al 1985. In essa, il mito classico e la tragedia contemporanea si fondono in una riflessione sulla rinascita attraverso la cultura, un tema che percorre tutta la sua opera. Trasferitosi a Milano nel 1956 — città che nel 2019 gli ha conferito l’Ambrogino d’Oro —, Isgrò partecipa a quattro edizioni della Biennale di Venezia (1972, 1978, 1986, 1993) e vince nel 1977 il primo premio alla 14ª Biennale di San Paolo.
Le sue opere sono state esposte in sedi prestigiose come il MoMA di New York, la Fondazione Peggy Guggenheim di Venezia e il Centre Pompidou di Parigi. Le retrospettive a lui dedicate — dal Centro Pecci di Prato nel 2008 a Isgrò cancella Brixia nel 2022, fino all’ampia antologica L’Opera delle formiche (2025) al Museo d’Arte Contemporanea del Carmine di Scicli — testimoniano una ricerca coerente e in continua evoluzione, dove ogni gesto di cancellatura diventa un atto di creazione. Le sue opere fanno oggi parte delle collezioni degli Uffizi, del Quirinale, della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, del Museo del Novecento di Milano, del Mart di Rovereto, oltre che di musei internazionali come il Pompidou, i Musées Royaux di Bruxelles e le istituzioni di Gerusalemme e Tel Aviv.